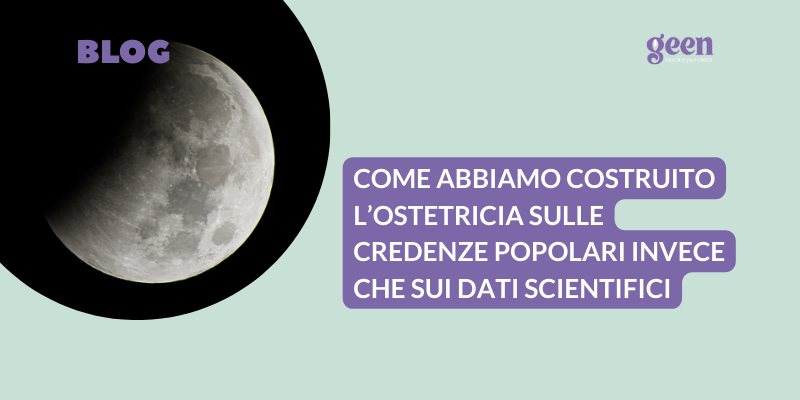a cura di Rosie Audino, esperta in filosofia e comunicazione della scienza e della salute
Nell’episodio 18 della sesta stagione di The Big Bang Theory, Leonard, Sheldon e Howard, impegnati in un progetto universitario legato all’inclusione nelle STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics), devono trovare un modo per incoraggiare più ragazze a intraprendere studi scientifici. Decidono così di andare a parlare in una scuola elementare. Prima di presentarsi, discutono del tema e riflettono su come, storicamente, molte donne abbiano dovuto mascherare la propria identità per evitare pregiudizi: da J.K. Rowling, che ha scelto di usare le iniziali, a Dorothy Fontana di Star Trek, che firmava come “D.C. Fontana” per essere presa sul serio come sceneggiatrice.
Anche le carriere scientifiche e tecnologiche, ancora oggi, sono segnate da importanti disuguaglianze di genere. Lo sapevi che, a livello globale, solo il 22% delle donne che studiano discipline STEM riesce effettivamente a lavorare in questi settori? E che appena il 2% dei capitali di investimento va alle start-up fondate da donne?
Queste disparità non riguardano solo i numeri: affondano le radici in una lunga storia di esclusioni. Le storie di due figure emblematiche - James Barry / Margaret Ann Bulkley e Lynn Conway - mostrano quanto profondamente il genere abbia determinato, in epoche diverse, chi potesse studiare, lavorare e innovare.
La storia di Margaret Ann Bulkley
Nel 1867, a Londra, il medico militare James Barry muore dopo una vita avventurosa al servizio dell’esercito britannico. Solo la domestica, quando la trovò dopo un lungo periodo di malattia morta nella sua stanza, preparando il corpo, scopre quello che poi l’esercito avrebbe nascosto per oltre cento anni: James Barry era nata donna. Il suo nome era Margaret Ann Bulkley. All’inizio dell’Ottocento, una donna non poteva accedere all’università né tantomeno alla chirurgia. Per studiare medicina a Edimburgo e costruirsi una carriera, Margaret dovette assumere un’identità maschile. Sotto mentite spoglie, Margaret, non solo completò gli studi, ma superò brillantemente l’esame del Royal College of Surgeons e divenne Ispettore Generale degli ospedali militari in Canada.
A Città del Capo eseguì con successo uno dei primi tagli cesarei moderni in cui sopravvissero sia la madre che il neonato, chiamato, non a caso, James Barry Munnik.
Una storia che sembra lontana secoli, ma che parla molto anche del presente.
La storia di Lynn Conway
Un secolo dopo, la scienziata informatica Lynn Conway avrebbe rivoluzionato il modo in cui progettiamo chip e architetture digitali. Le sue scoperte sono alla base della microelettronica moderna e alimentano ancora oggi smartphone, computer e tecnologie di rete. Eppure, nel 1968, mentre lavorava in IBM, Conway fu licenziata dal CEO Thomas J. Watson, Jr., dopo che l’azienda venne a conoscenza del suo percorso di transizione di genere. Una decisione che oggi sarebbe illegale. Lynn non si fermò. Completò la transizione e ricominciò da zero, con una nuova identità professionale. La sua fu una carriera brillante divenne Vice Direttrice per il Calcolo Strategico alla DARPA; Professoressa di ingegneria e informatica all’Università del Michigan (1985); figura chiave dell’innovazione informatica dalla fine degli anni ’60. Lynn rivelò la sua storia solo nel 1999. Come disse lei stessa: “Negli anni ’70 ero vista come una donna che aveva superato la barriera di genere nell’informatica. Nel 2000, quella barriera era diventata transgender.” Nel 2024 il Time l’ha riconosciuta come una delle figure LGBTQ+ più influenti del nostro tempo.
Cosa ci insegnano queste due storie
Margaret e Lynn non sono eccezioni romantiche. Sono due esempi estremi di un fenomeno molto semplice: il talento non basta, se il sistema non ti vede o ti esclude.
La leaky pipeline: dove si perdono i talenti
Leaky pipeline letteralmente tubo che perde è un fenomeno che descrive perfettamente cosa accade nelle carriere scientifiche: ad ogni passaggio - formazione, dottorato, ricerca, leadership - una quota sempre maggiore di donne abbandona.
Secondo il report UNESCO (2021):
il 44% delle persone con PhD è donna, il 33% delle ricercatrici nel mondo è donna, solo 22% lavora nell’Intelligenza Artificiale e appena 2% dei capitali di investimento va alle start-up fondate da donne.
Il sistema non perde talenti perché mancano interesse o competenze, ma perché mancano opportunità e condizioni paritarie.
Persone transgender e non-binary nelle STEM
Se già i dati sulle donne mostrano forti asimmetrie, la situazione è ancora più complessa per le persone transgender e non-binary. Un’analisi del 2025 ha mostrato che oltre il 70% degli studi accademici STEM usa ancora solo le categorie uomo/donna e solo il 5% prevede identità di genere più ampie.
Questo significa una cosa sola: non sappiamo quante persone trans e non-binary lavorano o studiano nelle STEM. E ciò rende impossibile monitorare la loro rappresentanza reale, osservare dove incontrano barriere e di conseguenza progettare politiche o programmi di inclusione efficaci.
Se non ci sono i dati, non c’è il problema e quindi niente soluzione…
Infatti, quando un gruppo viene escluso o considerato marginale, la scienza diventa meno rappresentativa, i dati meno affidabili e le innovazioni meno utili per l’intera popolazione.
I dati dell’UNESCO lo mostrano chiaramente: la produzione scientifica continua a riflettere quasi esclusivamente la prospettiva maschile. Questo significa che i bisogni e le specificità di almeno metà della popolazione vengono sistematicamente trascurati. Nel libro Invisibili di Caroline Criado Perez, che affronta con rigore questo tema, emerge un dato sconvolgente: il fatto che i piani alti della scienza e, in particolare, della medicina siano ancora rappresentati da una prevalenza maschile influenza direttamente la direzione della ricerca e, di conseguenza, le sue applicazioni pratiche. In altre parole, la ricerca tende a essere modellata su un corpo standard maschile. Perez mostra come molti farmaci di uso comune siano stati testati quasi esclusivamente su uomini, nonostante sia ampiamente documentato che le donne possano manifestare effetti collaterali diversi o più gravi. Non solo: spesso non si investe nello sviluppo di farmaci destinati a condizioni che colpiscono principalmente le donne, come la dismenorrea, semplicemente perché non se ne riconosce la rilevanza clinica ed economica. L’autrice osserva inoltre come, in parte della comunità scientifica maschile, persista una forma di negazionismo rispetto al “gender data gap”: la mancanza di dati disaggregati per genere e di una reale inclusione delle donne nei protocolli di ricerca. Un esempio significativo è lo studio pubblicato nel 2018 sul British Journal of Pharmacology, intitolato Gender differences in clinical registration trials: is there a real problem? La tesi degli autori (tutti maschi) è che, nei trial clinici necessari per l’approvazione dei farmaci, le donne non risultino numericamente sottorappresentate. Tuttavia, il limite sostanziale dello studio è che, pur essendo presenti, i dati non erano disaggregati per genere. Questo impedisce di comprendere se e come il farmaco agisca diversamente nei due sessi. Ed è qui il nodo centrale: non basta includere le donne dal punto di vista numerico; è indispensabile capire come i farmaci funzionano su corpi diversi. Solo così possiamo parlare di una vera medicina di genere.
Senza voler trarre conclusioni affrettate, è plausibile ipotizzare che la forte sottorappresentazione delle donne nei settori STEM si rifletta anche nel modo in cui viene progettata e condotta la ricerca. Se chi definisce le priorità scientifiche appartiene in larga maggioranza a un unico gruppo, per genere, background o esperienza, è inevitabile che alcune domande vengano poste e altre no, che certi problemi emergano e altri rimangano sullo sfondo. La scarsità di sguardi femminili nei ruoli decisionali non è solo una questione di equità professionale, ma ha conseguenze concrete sulla qualità, sulla completezza e sull’utilità della scienza che produciamo. Lo vediamo chiaramente anche nei dati UNESCO: solo il 2% degli investimenti globali in innovazione è destinato alla femtech, un’area che comprende tecnologie pensate per rispondere ai bisogni di tutte le persone che, per genere, identità, caratteristiche biologiche o condizioni di salute, risultano storicamente sottorappresentate e poco considerate nei percorsi di ricerca tradizionali. Ed è un grande limite, perché proprio in un settore che dovrebbe promuovere progresso, inclusione e creatività, molte esigenze reali restano invisibili o marginali.